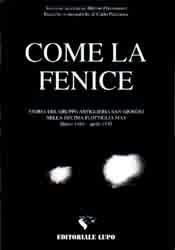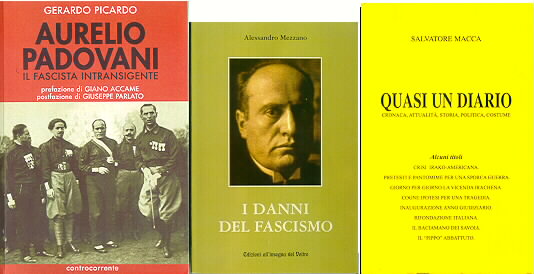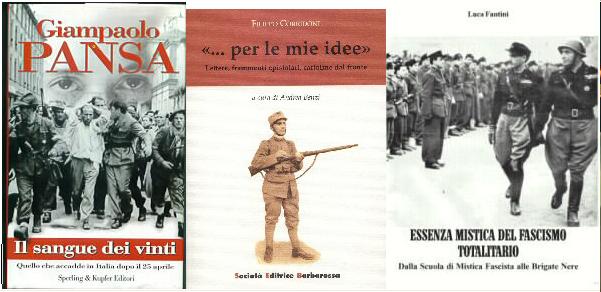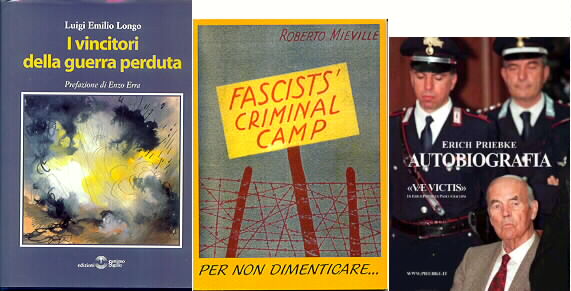Pansa Giampaolo IL SANGUE DEI VINTI
Sperling & Kupfer, 2003
Esce "Il sangue dei vinti", il nuovo libro di Giampaolo Pansa."Dopo
le atrocità dei repubblichini, l'altra faccia della medaglia"
Quei fascisti uccisi dopo il 25 aprile
di SIMONETTA FIORI
Intervista a Giampaolo Pansa
ROMA - E' una pagina orrenda della storia italiana del Novecento. Storie
di impiccati e traditori, di stupri e torture, di fucilazioni di massa ed
efferatezze gratuite, di cadaveri irrisi e violati, della furia vendicativa
che travolse il Nord d' Italia alla fine della guerra. Storie laceranti e
dolorose, perché nelle vesti di aguzzini e seviziatori, tra il maggio
del 1945 e la fine del 1946 (talvolta anche più in là), s'
incontrano alcuni dei partigiani che avevano liberato il paese da nazisti
e fascisti.
E tra le vittime, ritratte nella luce livida della morte, uomini della Guardia
Nazionale Repubblicana, brigatisti neri, federali di Salò, ma anche
farmacisti, avvocati, artigiani, commercianti, operai, casalinghe, maestre
elementari, affittacamere, talvolta condannati alla forca soltanto per una
tessera del Partito fascista repubblicano. Per quasi sessant' anni questa
vicenda è rimasta avvolta in un velo di reticenze e di silenzi imbarazzati.
La racconta ora, con la passione storiografica degli esordi e la limpidezza
del narratore sapiente, Giampaolo Pansa, in un libro - Il sangue dei vinti
(Sperling & Kupfer, pagg. 382, euro 17, dal 14 ottobre in libreria) -
che susciterà polemiche non lievi.
"Dopo tante pagine scritte, anche da me, sulla Resistenza e sulle atrocità
compiute dai tedeschi e dai repubblichini, mi è sembrato giusto far
vedere l'altra faccia della medaglia. Ossia quel che accadde ai fascisti
dopo il crollo della Repubblica sociale italiana".
Il risultato è un viaggio attraverso l'orrore compiuto dall'autore
insieme a Livia, una bibliotecaria quarantenne che è l'unico personaggio
inventato del racconto. Meticolosa e sconvolgente è la mappa dei crimini.
Scuole e ville trasformate in luoghi di tortura. Uomini gettati vivi nei
forni delle acciaierie. Fiumi gonfi di cadaveri sfigurati. Un'intera colonna
di soldati - la "Morsero" - esposta al linciaggio popolare, esecuzioni di
massa sul Piave, assalti furibondi alle carceri, donne stuprate e poi finite
con una pallottola.
A Milano, Torino, in tanta parte della Liguria, nel Veneto, in Emilia.
E tanto più feroce era stata l'occupazione nazifascista, quanto più
furiosa esplode la vendetta. Soltanto alla fine di questo viaggio scopriremo
che Livia è figlia d'un ex partigiano della Volante Rossa (la squadra
che nel dopoguerra a Milano seminò terrore tra gli ex repubblichini)
e con quel controverso passato vuol fare i conti.
Lei, Pansa, perché ha voluto aprire una pagina così spinosa?
"Avevo diciannove anni quando cominciai a studiare la storia della Resistenza.
A quella straordinaria vicenda civile ho dedicato con slancio la mia tesi
di laurea, avviata con Alessandro Galante Garrone e conclusa con Guido Quazza,
i miei maestri. Da allora ho continuato a scriverne, con una curiosità
mai soddisfatta: ma cosa è realmente accaduto alla fine della guerra?
Nessuno mi ha mai dato una risposta. Non gli accademici, per cui la storia
si concludeva con il 25 aprile. Né la storiografia di sinistra, che
per opportunismo partitico o faziosità ideologica ha quasi sempre
ignorato quegli avvenimenti. A sessantasette anni mi sono detto: ma perché
non provare a raccontare il 'dopo 25 aprile'?".
Nessun disagio nel confrontarsi con una materia così incandescente?
"No, perché dovrei? Sono un ex ragazzo di sinistra, ho un pedigree
antifascista, l'eroe per antonomasia è il partigiano che liberò
la mia città, Casale Monferrato. Ma ho sempre saputo che la guerra
civile è una scuola terribile per tutti. Ti abitua alla violenza disumana.
Chi sostiene che soltanto una parte s' è macchiata di pratiche bestiali
sa di dichiarare il falso. Quello schifo l'abbiamo visto in entrambi i campi
e io ho voluto raccontare quel che è accaduto nel mio campo".
Claudio Pavone, che per primo ha sdoganato a sinistra il termine di "guerra
civile", scrive che crudeli e sadici furono presenti nelle due parti in lotta
(in numero senza confronti superiore tra i repubblichini) e tuttavia ciò
che differenzia i due fronti è la diversa struttura culturale di fondo,
più adatta nel caso dei fascisti a selezionare crudeltà e sadismo.
"Ma ciò che sconvolge, nei mesi successivi al 25 aprile, è
l'indistinta caccia al fascista, che poteva essere un criminale di guerra,
o soltanto un tesserato del Pfr, oppure niente di niente. La morte come una
falce impazzita, che non distingue l'erba buona da quella cattiva. Famiglie
intere spedite sottoterra, per un semplice sospetto. Complessivamente furono
oltre ventimila le persone, tra militari e civili, che rimasero travolte
dalla resa dei conti e dagli omicidi politici. Desaparecidos d' una guerra
brutale".
Come spiega tanta violenza?
"Intanto fu una reazione istintiva alla spietatezza degli occupatori nazisti
e dei fascisti collaborazionisti. Non a caso tanto più feroce era
stata l'azione di tedeschi e repubblichini, quanto più cruenta fu
la ribellione. Senza contare le vendette personali: dietro molte esecuzioni,
c' era una resa dei conti privata".
Lei scrive che dietro questa furia violenta agiva anche un'illusione.
"Era diffusa la convinzione che più fascisti venivano accoppati, minore
sarebbe stata la possibilità di rinascita del fascismo. Un'illusione
fallace".
Oggi gli eredi di quella storia sono al governo.
"Sì, è così. Anche se Fini non può essere inchiodato
al suo passato fascista, così come Fassino non può essere impiccato
alle sue radici comuniste".
Furono numerosi allora i giustizieri improvvisati.
"Spuntarono ovunque tantissimi partigiani finti. Ci sono le testimonianze
di Italo Pietra e del socialista Gianni Baldi: scendevano in campo gli antifascisti
dell'ultim' ora, decisi a mettersi in bella vista in soccorso del vincitore".
Su quali fonti storiografiche ha lavorato?
"Ho dovuto camminare sulle sabbie mobili di fatti lontani, che spesso hanno
lasciato poche tracce. Mi ha soccorso una vasta memorialistica di parte -
disseminata presso sigle editoriali minori, quasi invisibili - oltre che
i censimenti dei caduti della Rsi, mentre nell'ambito della letteratura di
segno opposto non c' è granché, tranne i preziosi contributi
di Massimo Storchi, Gianni Oliva e Mirco Dondi. Gli istituti storici della
Resistenza, su questo argomento, hanno prodotto molto poco".
Ma le testimonianze di parte fascista non rischiano di essere faziose,
devianti?
"No, non c' è questo rischio. Tutte le storie che ho raccolto in
questo libro sono assolutamente credibili. Il mio difetto è averne
tralasciato un'enorme quantità".
Tra tutte colpisce la pagina dedicata a un personaggio-simbolo, Arrigo
Boldrini, presidente dell'Anpi. Lei definisce i suoi uomini "eroici e spietati".
Ne racconta la ferocia esercitata a Codevigo, in Veneto, contro i fascisti
ravennati.
"Boldrini è stato un grande comandante militare, intelligente e coraggioso.
Nel febbraio del 1944 ottenne una medaglia d' oro dagli inglesi. Ma a Codevigo
tutti ricordano ancora quel che accadde alla fine della guerra: gli uomini
di Bulow era meglio non trovarseli davanti, né di giorno né
di notte".
Non teme di sfigurare un'icona?
Ma no, quella era una guerra spietata. Se avessi avuto dieci anni di più,
mi sarei trovato al loro fianco".
Lei Pansa affronta anche un altro argomento tabù, il cosiddetto
triangolo della morte, i delitti commessi nel dopoguerra in Emilia da partigiani
comunisti.
"Sì, fu l'inizio d'una seconda guerra civile. Una guerra di classe
che avrebbe potuto fare da innesco a una rivoluzione comunista. Si cominciarono
ad ammazzare i preti, gli agrari, i borghesi ricchi. Il vero drammatico problema
era che nel partito di Togliatti, di Longo, di Secchia e di Amendola, l'intero
gruppo dirigente, compresi i capi locali, non fece nulla per stroncare alla
radice questa convinzione".
Ma nel Pci, su queste violenze, ci fu uno scontro molto aspro.
"Esisteva un partito deviato, all'interno del partito legale. Gruppi clandestini
che godevano dell'appoggio di non pochi dirigenti del Pci reggiano. Finché
Togliatti, nel settembre del 1946, disse basta. Di lì a poco il vertice
della federazione reggiana venne silurato. Hanno ragione Elena Aga Rossi
e Viktor Zaslavsky quando sostengono che le vendette e poi l'epurazione miravano
a indebolire un'intera classe, la borghesia, e a sostituire il vecchio ceto
dirigente con una nuova leadership in cui il Pci fosse rappresentato".
Pansa, mi viene in mente l'obiezione mossa da un dirigente cattolico del
Cnl, Pasquale Marconi, a un bel personaggio del suo racconto, il Solitario,
che pagò con la vita la sua ansia di verità.
"Se è lecito che si faccia luce e giustizia, non è bene rimestare
continuamente tutto quello che vi può essere stato di marcio nella
causa partigiana: rischieremmo di essere ingiusti verso quello che c' è
stato di bello".
Lei non vede questo rischio, oggi?
"No, affatto. Potrei rispondere con un motto di Giancarlo Pajetta: 'La
verità è sempre rivoluzionaria'. Il marcio che pure vi fu tra
le file partigiane non cancella le pagine eroiche. E non azzera la distinzione
tra le due parti in lotta: gli uni combattevano per la libertà, gli
altri al fianco della dittatura nazifascista. Mi chiedo soltanto se i vincitori
di quella guerra non sarebbero potuti essere più clementi con l'avversario".
Un libro sui partigiani rossi lordi di sangue non rischia di essere inopportuno
in un paese guidato da un premier che elogia la benevolenza di Mussolini?
"Ma io non sono un uomo da opportunità! Io me ne infischio. Quel
che dice il cavaliere sul regime fascista è un discorso da ubriaco.
Penso che la partita con Silvio Berlusconi vada giocata su un altro terreno,
spiegando che quella maggioranza porta il paese al disastro".
Tra i valori oggi in gioco c' è anche l'antifascismo.
"Ma il mio è un grande servizio reso all'antifascismo. Questa storia,
di morte e vendetta, la raccontiamo fino in fondo noi che veniamo da quella
parte. Gianfranco Fini non lo fa. Di Salò non vuole parlare".
I vinti di allora sono i vincitori di oggi.
"L'ho già detto, ammazzare i fascisti non è servito a niente.
Anche se la destra di oggi, ripeto, è una cosa diversa".
Pansa, non si sorprenderà se il suo libro susciterà discussione.
"Quelli della mia parte s' arrabbieranno. Ma a me piacciono i dibattiti furibondi.
Voglio continuare a scrivere libri "politicamente scorretti", scuotere certezze
acquisite. Saranno i lettori a giudicarmi. Il mio lavoro precedente, I figli
dell'aquila, protagonista un ragazzo di Salò, ha venduto ottantamila
copie, e vinto il premio Acqui Storia. Se qualcuno s' incavola, faccia pure:
io vado avanti".
FONTE: LA REPUBBLICA (tramite sito in Internet) del 10 ottobre
2003
***
I PADRONI DELLA MEMORIA. La storia scritta (e riscritta) sempre a
sinistra
Galli Della Loggia Ernesto
C' è davvero qualcosa di singolare nel modo in cui è venuta
formandosi la memoria della Repubblica, nel modo in cui tale memoria è
stata ed è elaborata dalla cultura ufficiale del Paese. Per molti
decenni, ad esempio, a quanto accaduto dal 1943 al ' 45 fu vietato dare il
nome che gli spettava, il nome cioè di guerra civile. Parlare di guerra
civile era giudicato fattualmente falso, e ancor di più ideologicamente
sospetto. Bisognava dire che quella che c' era stata era la resistenza, non
la guerra civile; di guerra civile parlavano e scrivevano, allora, solo i
reduci di Salò, i nostalgici del regime e qualche coraggioso giornalista
o pubblicista di rango come Indro Montanelli, che mostravano così
da che parte ancora stavano. Le cose andarono in questo modo a lungo. Finché,
all' inizio degli anni Novanta, come si sa, uno storico di sinistra, Claudio
Pavone, scrisse un libro sul periodo 1943-' 45 che si intitolava precisamente
Una guerra civile: solamente da allora tutti abbiamo potuto usare senza problemi
questa espressione, ben inteso non cancellando certo la parola resistenza.
Altro esempio: il cosiddetto "triangolo della morte", ovvero le uccisioni
indiscriminate di fascisti e non commesse dai partigiani dopo il 25 aprile.
Anche qui è valsa fino ad oggi la regola che bisognava negare che
quelle uccisioni fossero avvenute, per lo meno che fossero avvenute su larga
scala e assai spesso con efferatezza e gratuità spaventevoli. Solo
quelli di Salò e i neofascisti ne parlavano, naturalmente si può
immaginare come. Il discorso storico ufficiale, invece, al massimo e solo
dopo molte riluttanze arrivava alle mezze ammissioni: più in là
c' era ancora una volta il divieto del politicamente e dello storiograficamente
corretto; finché con il recente libro di un noto e bravo giornalista
di sinistra, Giampaolo Pansa (Il sangue dei vinti), il divieto è stato
tolto, sicché ora siamo tutti finalmente autorizzati a conoscere e
a discutere liberamente gli avvenimenti di quei terribili giorni. Ma mi domando:
non è singolare che su due aspetti così significativi della
fondazione del nostro presente, la memoria ufficiale del Paese abbia per
tanto tempo preferito guardare dall' altra parte? E non è ancor più
singolare che a conti fatti su entrambi quei nodi di eventi la versione anche
lessicalmente più vicina alla verità non fosse quella della
democrazia repubblicana e della sua memoria bensì quella dei suoi
nemici? Ma le singolarità non finiscono qui. C' è anche il
non trascurabile particolare che è solo nel momento in cui personalità
culturali di sinistra decidono che è giunto il momento di cambiare
la versione fin lì consacrata dei fatti, è solo allora che
il Paese si sente autorizzato a prendere ufficialmente conoscenza di parti
di verità che fino ad allora, viceversa, si riteneva ideologicamente
più opportuno far finta di ignorare; è solo allora che giornali,
televisioni, opinione pubblica, si sentono in grado di poter discutere liberamente.
Non solo, ma, come ha ricordato Otello Montanari in una lunga lettera al Foglio,
capita addirittura che proprio l' odierno denunciatore delle stragi del dopo
25 aprile, proprio lui solo una decina di anni fa giudicasse negativamente
e con pesante sarcasmo il suddetto Montanari che, pur militando da sempre
nel Pci, cercava già allora di sollevare il velo della verità
su quelle indiscriminate uccisioni; che cercava cioè di fare in anticipo
la medesima cosa che lui stesso fa oggi. Siamo una democrazia, insomma, che
per troppo tempo ha avuto un rapporto problematico con la verità delle
sue origini. E che dunque ha avuto un rapporto egualmente problematico con
l' anima profonda del Paese che invece quella verità sapeva, o spesso
intuiva, ma non poteva né sapeva dire. Una democrazia troppo abituata
a praticare innanzitutto sulle proprie stesse vicende il conformismo culturale,
l' ossequio alle versioni di comodo, a incensare come maestri gli araldi
del primo e i fabbricanti delle seconde. Siamo una democrazia nata con una
difficoltà profonda a fare i conti con il passato e che, forse anche
per questo, si è poi trovata costretta in sessant' anni ad assistere
tanto spesso senza batter ciglio al repentino cambiamento di senso che ha
colpito il passato di tante biografie politiche: ieri postlittorie o postmonarchiche,
oggi postfasciste, postcomuniste, postcraxiane, domani chissà postberlusconiane
o postleghiste. Siamo una democrazia in cui la chiave della memoria pubblica
è ancora e sempre nelle mani di una parte sola, non da ultimo a causa
dell' incapacità e dell' inconsistenza culturale dell' altra, la quale,
trovandosi tagliata fuori dall' elaborazione attiva e riconosciuta del passato
collettivo, è come se si trovasse essa stessa senza radici e sempre
sul punto di essere espulsa da quel passato medesimo, di vedersi cacciata
dalla koinè nazionale. Fino a quando sarà così non lo
sappiamo: sappiamo solo che finché la memoria degli italiani non diverrà
finalmente la sua stessa memoria, la Repubblica sarà condannata ad
accontentarsi di una memoria sempre parziale e omissiva, a sentire sempre
incerto e provvisorio il suo presente proprio come sempre incerto e provvisorio
è il suo passato. Ernesto Galli della Loggia
IL CORRIERE DELLA SERA sabato, 1 novembre, 2003
***
SINISTRA PADRONA DELLA MEMORIA: DAGLI STORICI AUTOCRITICI E ACCUSE.
Lepre: è vero, ci siamo politicizzati. Rumi: effetto della sconfitta
comunista Tranfaglia: il problema è invece l' inconsistenza culturale
della destra Sabbatucci: impostazione figlia della Rivoluzione francese pensare
che la legittimità sta solo da una parte. Dopo l' editoriale di Galli
della Loggia sul monopolio nella lettura del passato.
Fertilio Dario
«La storia è sempre scritta dalla parte del vincitore»
annotava amaramente Trotzky, dopo aver perso la sua battaglia contro Stalin
e imboccato la via dell' esilio. E qualcosa di vero doveva pur esserci, se
nell' articolo di fondo sul Corriere, ieri, lo storico Ernesto Galli della
Loggia ha denunciato un simile conformismo ortodosso a proposito della Resistenza.
Certo in Italia, a differenza della Russia, ha trionfato la democrazia: ma
come negare che, all' ombra delle truppe liberatrici, si siano fatti largo
i regolamenti di conti e gli atti di giustizia sommaria illustrati da Giampaolo
Pansa nel suo ultimo libro? E che proprio questi lati oscuri, a volte vergognosi,
siano stati considerati tabù dalla storiografia ufficiale, da sempre
allineata a sinistra? Ebbene, Galli della Loggia ha parlato chiaro: da noi,
almeno fino ad oggi, sono esistiti i «padroni della memoria»,
gli unici autorizzati a ripartire meriti e colpe delle nostre vicende comuni.
E, finché questi «padroni» l' hanno proibito, tutti i
saggisti e gli studiosi (o quasi) hanno rispettato disciplinatamente il silenzio.
Poi, prima con Claudio Pavone e più recentemente con Giampaolo Pansa,
il divieto è stato tolto: ma è accaduto soltanto perché
il via libera è venuto da personaggi schierati a sinistra? «Il
problema invece è tutto della destra - risponde polemicamente Nicola
Tranfaglia - perché a cinquant' anni dalla fine del fascismo essa
non riesce ancora ad affrontare adeguatamente quel periodo storico. Un po'
per sua inconsistenza culturale, e un po' perché sono temi che, si
vede, continuano a scottarla». Non nega, Tranfaglia, quegli «episodi
di giustizia anche sommaria» avvenuti «al di fuori delle regole
della legalità»: tuttavia, nota, «venivano pur sempre
dopo vent' anni di regime, e di crudeltà commesse dai seguaci di Salò».
Questo non autorizza nessuno, comunque, a parlare di «occupazione della
memoria»: «Le capacità non sono ereditarie, gli spazi
può prenderseli chi vuole». Sarà, ma secondo Piero Melograni
è storicamente vera, piuttosto, la spartizione delle zone d' influenza:
«La sinistra agli intellettuali ha promesso il potere, e si è
conquistato un' egemonia; la destra, al massimo, ha promesso loro dei soldi».
Tuttavia, ha l' impressione che le cose stiano cambiando in meglio: «L'
analisi di Galli della Loggia la trovo nell' insieme azzeccata, però
sono meno pessimista sul futuro. Oggi gli studiosi possono lavorare meglio
di prima, anche se parecchi anni di studio sono andati perduti, e poi l'
ostilità contro il revisionismo si sta esaurendo. Se alcuni politici
continuano a opporsi, dev' essere perché in fondo pensano che l' Italia
non possieda un' identità e una vera memoria condivisa. Poi dimenticano
di dire che se l' identità italiana esiste, ed è così,
dev' essere anche nel male, non solo nel bene». Come si potrà
arrivare allora a quella «memoria condivisa» auspicata da tanti?
«Identificandola con la capacità di comprendere le ragioni degli
altri: vale per la destra nei confronti della sinistra, e al contrario».
Il sostegno più convinto Galli della Loggia lo ottiene sul versante
cattolico: Giorgio Rumi concorda in pieno sulla denuncia di «un' egemonia
di sinistra sulla storia, al punto da far sentire a tutti, oggi, umiliante
e scandaloso l' averla tollerata». Se le cose sono cambiate, a suo
giudizio, è in parte merito di De Felice, «il primo che ha avuto
il coraggio di sollevare questo macigno», ma si può considerare
anche un semplice effetto della sconfitta storica dei regimi comunisti. «Le
cose sono cambiate dopo l' 89 e il ' 91, è venuto meno quello "spirito
satellite" che a sinistra la faceva da padrone. Se ne vuole una controprova
paradossale? Proprio la storiografia di sinistra, in tutti questi anni, ha
continuato sistematicamente a sottovalutare il ruolo dell' Armata Rossa,
non meno che degli alleati anglo-americani, nella liberazione dal nazismo.
Il motivo è stato tattico: si preferiva lasciare in ombra gli aspetti
considerati, per un motivo o per l' altro, imbarazzanti, e puntare tutto
sulla guerra di liberazione, un argomento su cui era ovvio che tutti fossero
d' accordo». Se si vuole un' autocritica a sinistra, ebbene Aurelio
Lepre è pronto a farla: «Negli anni del dopoguerra noi progressisti
ci siamo troppo politicizzati, abbiamo considerato i nostri studi storici
come un modo di fare politica». E il tema, anch' esso toccato da Galli
della Loggia, della «guerra civile»? Non è vero che è
stata a lungo negata, solo perché rischiava di oscurare l' aspetto
eroico della Resistenza? «Guerra civile ci fu tra italiani - risponde
Lepre - mentre la Liberazione fu quella dai tedeschi. Resistenza invece è
un termine più generico: significa che la popolazione, pur non partecipando
sempre attivamente alla lotta, stava in generale dalla parte dei partigiani,
si opponeva alla continuazione di una guerra che appariva ormai inutile».
Una discussione, comunque, che non si applica solo all' Italia: Giovanni
Sabbatucci trova molte somiglianze tra noi e la Francia, quest' ultima spaccata
a suo tempo attorno al tema della resistenza antigiacobina in Vandea, o sulla
repubblica di Vichy e le responsabilità del collaborazionismo. «La
nostra storia europea, anche quella contemporanea, resta sempre figlia della
rivoluzione francese. Di conseguenza, si tende a pensare che la legittimità
sia solo a sinistra, e ad essa spetti naturalmente un' egemonia culturale.
Un effetto? Da noi anche il Risorgimento è stato possibile finora criticarlo
soltanto da sinistra. La destra, già malconcia, è uscita definitivamente
delegittimata dalla disavventura del fascismo. «Certo - conclude Sabbatucci
- è scoraggiante ritrovarci ancora oggi, nel 2003, a discutere le
legittimità di un libro come quello di Pansa. Un' arretratezza di
cui dovremmo vergognarci un po' ».
IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,
Pag. 013)
***
Il dibattito MEMORIA
In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera di ieri, Ernesto
Galli della Loggia ha posto il problema dei «padroni della memoria»:
per decenni la storiografia, appannaggio della sinistra, non ha parlato di
guerra civile per gli anni dal 1943 al 1945 e non ha fatto luce adeguata sui
delitti commessi dai partigiani dopo il 25 aprile REVISIONISMO All' inizio
degli anni Novanta l' atteggiamento della storiografia «ufficiale»
comincia a cambiare. Fondamentale il saggio dello storico di sinistra Claudio
Pavone, intitolato Una guerra civile, in cui si indagano i fatti del periodo
1943-' 45 LE VITTIME I federali di Salò, gli uomini della Guardia nazionale
repubblicana, ma anche semplici farmacisti, avvocati, e casalinghe con la
tessera del Pfr: sono le vittime della vendetta partigiana esplosa in modo
furioso in Emilia, Veneto, Toscana, Lombardia, Piemonte e Liguria
IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,
Pag. 013)
***
OPINIONI A CONFRONTO
PIERO MELOGRANI La sinistra agli intellettuali ha promesso il potere,
e si è conquistata un' egemonia; la destra, al massimo, ha promesso
loro dei soldi. Azzeccata l' analisi di Galli della Loggia, ma sono meno pessimista
sul futuro GIOVANNI SABBATUCCI La nostra storia europea, anche quella contemporanea,
resta sempre figlia della Rivoluzione francese. Di conseguenza, si tende
a pensare che la legittimità sia solo a sinistra, e ad essa spetti
naturalmente un' egemonia culturale NICOLA TRANFAGLIA Il problema è
tutto della destra perché a 50 anni dalla fine del fascismo essa non
riesce ancora ad affrontare adeguatamente quel periodo storico. Un po' per
sua inconsistenza culturale, e un po' perché sono temi che continuano
a scottarla AURELIO LEPRE Nel dopoguerra noi progressisti ci siamo troppo
politicizzati e considerato i nostri studi come un modo di fare politica.
Guerra civile ci fu tra italiani, Liberazione fu quella dai tedeschi. Resistenza?
Il popolo stava dalla parte dei partigiani
IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,
Pag. 013)
|